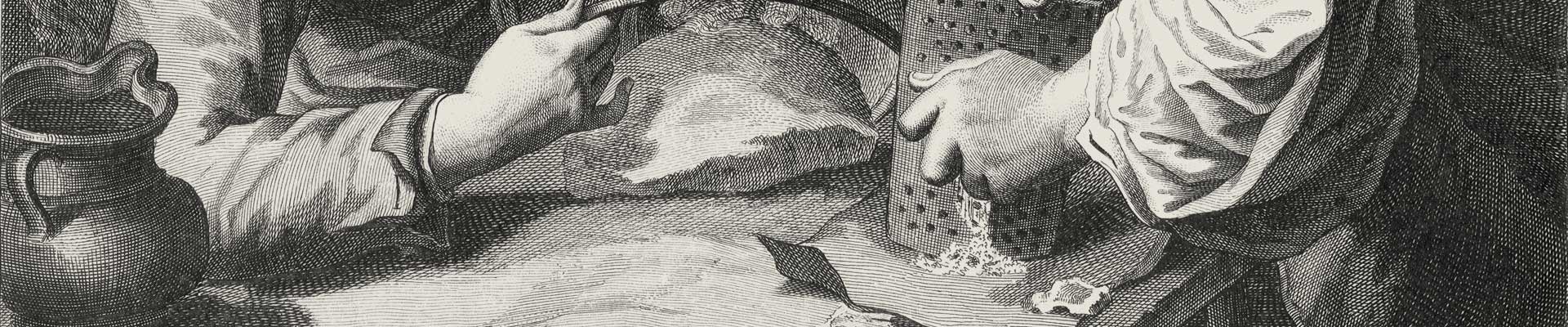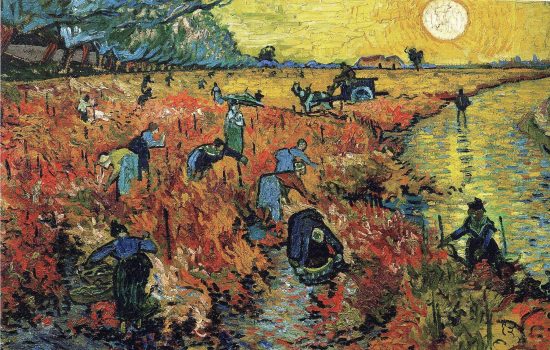Sede sì, sede no. Ovvero la protervia dell’inutile
di Daniele Pisanello – Lex Alimentaria Studio Legale
1. Veti incrociati sulla strada dell’adeguamento nazionale al Reg. (UE) n. 1169/2011
Mettiamoci l’anima in pace. Il legislatore italiano non è stato in grado di predisporre la normativa di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione del consumatore di alimenti, nei termini previsti a livello comunitario (13 dicembre 2014). E neppure è dato sapere se, quando e come si potrà far affidamento su un testo di legge di raccordo alla nuova cornice in materia di informazioni sui prodotti preconfezionati, non preconfezionati e di quelli somministrati in sede di ristorazione collettiva.
L’effetto negativo interessa tutti gli operatori del settore, in particolar modo il settore della ristorazione collettiva che trova nel Reg. (UE) n. 1169/2011 innovativi aspetti di regolazione che, peraltro, solo il legislatore nazionale è chiamato a disciplinare: basti pensare alle modalità di fornitura dell’informazione sugli allergeni presenti nelle pietanze somministrate oppure ai chiarimenti auspicabili in ambito di ristorazione ospedaliera o scolastica, ove l’applicazione pedissequa del requisito comunitario dell’art. 44, avrebbe riflessi prossimi alla irrazionalità più negletta (informare, per iscritto, un paziente magari in condizione di incapacità di intendere e volere?). Per non dire, volendo scendere in profondità, degli aspetti più aderenti alla modulazione dei piani di autocontrollo igienico che, in una ottica di full compliance, si pone come essenziale al fine di quella “garanzia” di assenza/presenza di allergeni e il connesso tema, spinoso in date circostanze, della contaminazione crociata. Aspetti che, come ben sa l’avveduto lettore, travalicano il piano della stretta compliance, avendo ricadute importanti in termini di responsabilità civile, sui profili assicurativi e financo della responsabilità penale.
2. Il casus belli: l’obbligo dell’indicazione della sede di confezionamento
Tornando al motivo dell’empasse nell’adeguamento italiano, sembrerebbe, stando per lo meno ai rumors, che vi sia una “diversità di visione” tra i due ministeri competenti (Sviluppo economico e Politiche Agricole) circa l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento: da un lato il MiSE, assertore dell’impossibilità di procedere alla (re)introduzione dell’obbligo di indicare la sede di produzione in quanto opzione espressamente inconciliabile col regolamento quadro. Dall’altro, il Ministero di via XX settembre (MiPAAF), latore e fautore del contrario. A leggere le cronache di febbraio 2015, si raccolgono ampi indizi che questo sia un tema, per così dire, divisivo.
È indubbio che, avvicinandosi la data del 13 dicembre 2014, sia crescita la discussione pubblica su alcuni temi connessi alla informazione del consumatore di alimenti: l’uso di oli vegetali, ad esempio, ma anche, per l’appunto, l’indicazione di origine declinata nella forma dell’obbligatoria indicazione della sede dello stabilimento sui prodotti preconfezionati. Vale la pena ricordare che quest’obbligo era stato previsto dal legislatore italiano (decreto legislativo n. 109/1992) per i prodotti realizzati in Italia e destinati al mercato italiano (precisazione doverosa, attesa la sbadataggine in cui spesso alcune autorità “competenti” incorrono), in virtù di una facoltà concessa dalla direttiva CE n. 2000/13 e non più riaffermata nel testo del Reg. (UE) n. 1169/2011.
Il venir meno della direttiva e la mancata previsione di una analoga norma nel nuovo regolamento ha avuto come effetto giuridico ineludibile che le indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfenzionati dovrebbero essere solo quelli di cui all’art. 9 del Regolamento e, per quel che qui conta, l’inapplicabilità del requisito di legge nazionale, formalmente ancora previsto dal decreto legislativo n. 109/1992.
Sicché ad avviso di taluno, il consumatore italiano sarebbe stato defraudato di tale informazione; ergo la necessità di re-introdurre l’obbligo. Ben inteso, considerazione tutto sommato condivisibile se posta alla base di una iniziativa politica e anche di una proposta legislativa, nelle competenti sedi e nel rispetto della legislazione applicabile. Peccato che, a voler ragionare sulla base del regolamento del 2011, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dopo quasi tre anni di discussione, nell’assordante disinteresse collettivo, la prospettiva di reintrodurre a livello nazionale l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione non sembrerebbe praticabile per almeno due ragioni giuridiche. Vediamone i motivi giuridici.
3. I perchè della protervia
In primis, nelle “materie armonizzate” dal regolamento, è fatto divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali (art. 38, Reg. (UE) n. 1169/2011). In secundis, agli Stati membri è concesso di “introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza” (art. 39, Reg. (UE) n. 1169/2011). Se ciò risponde al vero, l’idea che il legislatore nazionale possa introdurre legittimamente un nuovo obbligo di indicazione della sede di produzione, a carattere generalizzato, cioè valevole per tutti i prodotti alimentari preconfezionati, non è ipotesi realizzabile sul piano del diritto alimentare.
Sul piano più generale, la richiesta di introduzione dell’obbligo di indicazione della sede postula la assoluta necessarietà di siffatta informazione “al consumatore”. Orbene, se tale bisogno informativo sussistesse, e cioè fosse presente un cluster significativo di consumatori pronti a riconoscere un quid pluris monetizzabile (un premium price) per quell’informazione addizionale, il mercato si sarebbe attivato ben prima del legislatore su base volontaria.
Invece, eccezion fatta per i prodotti a marchio DOP-IGP, non risulta che vi siano settori merceologici nei quali tale esigenza abbia portato alla creazione diffusa di filiere volte a garantire quel tipo di informazione. Sembra lecito ritenere, in altri termini, che la richiesta di un intervento legislativo quale quello sopra descritto sia viziata in radice da un assunto non dimostrato: che il consumatore medio sia pronto a premiare i prodotti italiani, corrispondendo un prezzo superiore in ragione solo della provenienza.
Stupisce, infine, la scarsa considerazione in cui i vincoli giuridici (comunitari) sono tenuti dai sostenitori delle campagne colle quali si chiede al Governo nazionale di introdurre un obbligo generalizzato di indicazione della sede di produzione.
Sembra prefigurarsi, se queste preci fossero accolte a livello nazionale, un nuovo intervento legislativo palesemente in contrasto col diritto comunitario (e come tali disapplicabile), con connessa messe di contestazioni (spesso anche penali) per le relative violazioni, oberando gli operatori dell’onere di adire un giudice per veder riconosciuta la bontà del proprio agire.
Basta far mente locale ai fascicoli aperti a seguito di controlli mirati alla tutela del “made in Italy” (sic!) che, per bandierine tricolori o diciture equipollenti su prodotti alimentari fabbricati sul suolo repubblicano ma con ingredienti non esclusivamente italiani, hanno portato all’imputazione per asserite violazioni dell’art. 517 codice penale in combinato con l’art. 4 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), legge per averne – triste – conferma.
Disposizione quest’ultima che, in quanto non notificata in sede europea, e in ogni caso in palese violazione del diritto comunitario relativo alla etichettatura degli alimenti, non avrebbe dovuto mai essere applicata (oltre alla circostanza che i decreti attuativi sono rimasti lettera morta…).
Tant’é, i funzionari della Pubblica Amministrazione a volte preferiscono applicare solo la legge nazionale e ignorando che la Corte di giustizia, in uno con la Corte di cassazione, abbia da tempo sancito che “esattamente come il giudice nazionale, la pubblica amministrazione, ivi compresa quella comunale, ha l’obbligo [omissis] di disapplicare le norme nazionali che siano con esso in contrasto” con il diritto comunitario.
E, dunque, la domanda alla fine diviene: perchè in questo raggrinzito paese si è capaci di invocare il ferro (arrugginito, come si è visto) della legge, il factum principis, anche laddove meccanismi sociali improntati alla sussidiarietà potrebbero garantire traguardi più performanti con minor spreco di risorse, tempo ed energie?
10 marzo 2015